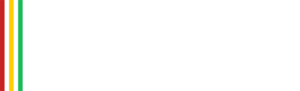Regia: Michel Gondry
Interpreti: Pierre Niney, Blanche Gardin, Vincent Elbaz, Camille Rutherford, Françoise Lebrun, Frankie Wallach, Dominique Valadié, Lucas Noël
Sceneggiatura: Michel Gondry
Produttore: Georges Bermann
Montaggio: Élise Fievet
Origine: Francia, 2023
Distribuzione: I Wonder Pictures
Durata: 102′
Sinossi:Marc Becker è un regista in piena crisi creativa e professionale. E il suo nuovo film, Chacun tout le monde, non convince i produttori, che vogliono rientrare dei loro investimenti, rivedendo drasticamente il montaggio. Disperato, Marc organizza un esilio temporaneo nella casa della zia Denise, nel cuore delle Cévennes, portando con sé l’assistente Sylvia e la montatrice Charlotte.
Nella quiete del villaggio la creatività sembra tornare ma Marc è tormentato: non riesce a concentrarsi sul montaggio originale e si perde in una miriade di altre idee. Progetta documentari su insetti, animazioni in stop motion, costruisce uno studio di montaggio su un camion, interrompe il lavoro per sperimentazioni statiche (come la “ripresa quotidiana della stessa formica”). Questa fuga artistica, passatempo produttivo e auto-narcotico, diventa quasi paradossale: più lui evita di finire il film, più sente l’esigenza di scrivere un vero e proprio “Libro delle soluzioni”, una raccolta di idee e stratagemmi per risolvere i problemi — sia pratici che esistenziali .
Il personaggio di Marc non è solo creativo, ma anche instabile: bipolarità, iper-reattività e passionalità esuberante contraddistinguono il suo carattere. Una compressa di energia che travolge troupe e familiari, trasformando la cinepresa in uno specchio della sua mente in subbuglio. Charlotte, la montatrice, è pragmaticamente esasperata, nel tentativo di riportare ordine al caos visivo, mentre Denise rappresenta l’anello rassicurante della famiglia e il rifugio dalle pressioni esterne.
Marc, in questo percorso, non assume solo il ruolo di cineasta in crisi, ma incarna lo stesso Gondry: riflessioni intime, inquietudini dell’autore e riferimenti alla travagliata post-produzione di Mood Indigo sono visibili in numerosi episodi — come l’ossessione a non rivedere le prime scene, o l’idea di montaggio non lineare, palindromico, per evitare la ripetitività .
A fare da contrappunto, compaiono personaggi come Gabrielle e persino un cameo di Sting, che sottolinea quanto la realtà del set si mescoli alla finzione personale di Marc.
Il film procede come un meta-cinema: un’opera cinematografica che riflette su se stessa e sui suoi processi, ponendosi domande sul catturare l’arte piuttosto che consegnarla alla logica produttiva. Il ritmo, oscillando tra commedia grottesca e momenti introspettivi tragici, segue la mente tormentata del suo protagonista. L’ironia e la tenerezza nascondono un’auto‑analisi profonda, un tributo all’infanzia, all’intelligenza creativa e al dolore esistenziale .
Il libro delle soluzioni è quindi un’opera atipica e affascinante, in cui Michel Gondry dirige un alter ego cinematografico per raccontare i dilemmi del fare cinema, come in una sorta di diario di sopravvivenza professionale, un labirinto di idee, autoinganni e speranze, capace di emozionare chi ama scoprire all’infinito il processo creativo.
Recensione:
Parte da un quaderno di appunti, il libro delle soluzioni appunto, e delle pagine bianche. Possono esserci delle regole che vanno dal metodo di lavorazione al rapporto con la troupe. Oppure possono restare lì, bianche, in attesa di essere riempite in ogni set. E per ogni film ‘il libro delle soluzioni può essere diverso’. Anche in Il libro delle soluzioni, il ‘cinema nel cinema’ è nella testa di Michel Gondry: piani B disperati dopo che i produttori ti hanno mollato, soluzioni di montaggio in un camion con il volante per mandare avanti e indietro quello che viene filmato e il clacson per tagliare, disegni animati con le vicende di Max le renard che è arancione, viene investito dalla macchina, usa le orecchie come forbici e apre un negozio di parrucchiere. Già in quest’ultimo disegno c’è un film da solo. Invece è un bozzetto, una delle tantissime, vulcaniche idee, da utilizzare o scartare. Gondry trova il suo alter-ego nel corpo di Pierre Niney nel ruolo di Marc, cineasta bipolare e paranoico che vuole difendere il suo nuovo film dagli attacchi dei produttori a cui non è piaciuto il girato. Accompagnato dalla sua
montatrice, fugge a casa della zia che abita nella zona delle montagne delle Cévennes per finire il film come lo vuole lui. Ma deve affrontare un ostacolo dietro l’altro a cominciare dal fatto di fare pace con sé stesso. Ha il ritmo e le gag di un cartoon con frequenti omaggi al cinema muto come nella scena in cui Marc dirige l’orchestra attraverso i movimenti del proprio corpo. A otto anni dal suo ultimo film, Microbo & Gasolina del 2015, Gondry inanella una serie di idee esplosivo che si scontrano una contro l’altra. Il libro delle soluzioni è l’elogio della creazione, la nostalgia per un cinema artigianale dove le soluzioni possono essere trovate sul momento attraverso un uso efficace degli oggetti come nel modo in cui il protagonista crea la pioggia con due innaffiatoi. Ci sono dietro i Lumière di L’arroseur arrosé? Il set diventa una polveriera: arriva Sting, torna ancora una zia come in L’épine dans le coeur che diventa ancora una figura umanamente fondamentale nella vita di Marc. Ci si perde, ci si innamora. C’è il cinema, c’è la vita di tutti i giorni. Non c’è più distinzione. Si potrà obiettare che il cinema di Gondry è questo e tende a ripetersi. Il libro delle soluzioni rappresenta ancora invece le infinite variazioni dello stesso film. C’è il tentativo di salvare il cinema a tutti i costi ed ecco che ritorna ancora il tema della memoria che non vuole essere cancellata, da Se mi lasci ti cancello a Be Kind Rewind. Gli acchiappafilm, dove le vhs cancellate in un negozio di vhs diventano ancora quelle pagine bianche da riempire. Divertentissimo, malinconico, imprevedibile, folle. Ogni inquadratura è una sorpresa, uno scatto improvviso in un cinema alla ricerca di regole e la sua genialità è proprio non trovare la soluzione per scegliere altre strade. Potrebbe essere la possibile versione di Effetto notte in stop motion in pura versione Gondry. Per Marc come per Ferrand/Truffaut il cinema è totale dipendenza.
Approfondimenti:
L’ambizione e l’ossessione
Dopo l’illuminazione, Jake ed Elwood si convincono di essere in missione per conto di Dio e che, per questo, qualunque cosa accadrà loro, alla fine, riusciranno nel loro intento proprio perché evidentemente protetti e guidati da una potenza superiore. È uno script veloce, fisico, ma al contempo impalpabile, quello di The Blues Brothers, in cui le situazioni si susseguono a cento all’ora ed i temi scorrono quasi senza peso di fronte allo spettatore ma non possiamo non ragionare sul modo in cui, attraverso una semplice battuta che viene rimpallata nel corso del racconto, Landis di fatto costruisca il suo film anche attorno ad uno dei temi centrali della letteratura e del cinema: l’ossessione.
Jake ed Elwood, anche in virtù dell’investitura sacra del loro compito non sembrano volersi fermare di fronte a nulla di ciò che si frappone tra loro ed i soldi necessari per salvare l’orfanotrofio, né i rifiuti degli ex componenti della band, spesso asserviti ai meccanismi della borghesia americana, né le aggressioni dei nazisti o la caccia organizzata contro di loro da “tutta la polizia dello stato”. Certo è che Landis, prevedibilmente, svuota uno spunto altrimenti densissimo di implicazioni ideologiche e lo utilizza soprattutto come paradossale detonatore di situazioni comiche e demenziali: non solo dunque basta solo alludere alla loro “missione” per convincere ogni membro della band a mettersi in viaggio con i fratelli Blues ma soprattutto l’alone sacrale che ammanta il cammino dei protagonisti sembra essere il motivo per cui i due riescono a sopravvivere senza un graffio alle aggressioni più efferate e violente che li coinvolgono, come quando l’ex fidanzata di Jake (Carrie Fisher) fa saltare in aria l’appartamento in cui lui ed Elwood stanno trascorrendo la notte.
Il tema ha costeggiato, ovviamente, quel cinema che in un modo o nell’altro ha raccontato storie su ambiziosi artisti in ascesa. Viene in mente a questo proposito un musical come All That Jazz, di Bob Fosse, in cui Roy Scheider interpreta un regista teatrale ossessionato dalla perfezione a tutti i costi, pronto a sacrificare tutto sull’altare dell’arte. Ma pensiamo anche ad un intero cinema, quello di Damien Chazelle che nei suoi momenti migliori ha saputo raccontare con grande cura l’ossessione dei suoi protagonisti, con tutto il suo carico di inquietudini, da Whiplash, storia di un batterista che pare perdere sé stesso mentre cerca di emergere tra gli allievi di una prestigiosa scuola di musica a First Man, sulla corsa allo spazio degli Americani, di fatto il racconto dell’ossessione della Nasa di arrivare sulla Luna prima dei Russi, costi quel che costi.
Ovvio che i risultati più efficaci, tuttavia, un tema del genere li ha raggiunti quando è stato fatto reagire con generi come il thriller psicologico o l’horror, come in The Prestige, di Christopher Nolan, in cui due prestigiatori iniziano una competizione senza esclusione di colpi alla ricerca del trucco più stupefacente e, forse, soprattutto, l’affascinante Number 23, di Joel Schumacher, in cui Jim Carrey interpreta un uomo che lentamente finirà per essere ossessionato per il numero 23, vero e proprio fantasma che infesterà la sua quotidianità.
La Musica, l’identità ed il pregiudizio
Si potrebbe discutere molto sull’idea di militanza attraverso l’arte che emerge in The Blues Brothers, raramente posta in primo piano all’interno della narrazione eppure sempre centrata, sviluppata con grande precisione. È, ovviamente, un discorso che emerge già da alcuni dei passaggi più noti e divertenti del film di Landis, a partire dall’astio che contrappone la band dei fratelli Blues ai nazisti dell’Illinois, un contingente dei quali viene quasi investito dai protagonisti durante una delle loro numerose fughe, ma una gag del genere è l’apice di un film che in realtà usa la musica per ragionare del rapporto che intercorre tra identità, pregiudizi e politica con straordinaria modernità.
Non sarebbe così scontato, in fondo, vedere nella band di Jake ed Elwood (non a caso “meticcia”, formata da musicisti bianchi e neri), un gruppo legato alle istanze del black pride, con radici ben piantate nella blackness del Rhythm And Blues, che costeggia i luoghi e le icone della soul music per proteggerli da una dimensione artistica che rischia di lasciarli in secondo piano. E allora, da questo punto di vista, forse, ben più degli screzi con i nazisti, fa gioco migliore all’idea di militanza portata avanti dal film il numero finale, con la band che suona Sweet Home Chicago di Robert Johnson nella cornice borghese all white dell’elegante Palace Hotel, roccaforte di una borghesia che spesso si rapportava al blues e alla cultura afroamericana con malcelato razzismo.
Senza arrivare al didascalismo del classico Billy Elliot, in cui il ragazzino protagonista rivendica la sua alterità nei confronti della società con cui si interfaccia combattendo il pregiudizio culturale che vorrebbero impedirgli di danzare, attività considerata poco virile rispetto al pugilato, il passo militante del Blues Brothers di Landis si ritrova forse da un lato in Velvet Goldmine, film musicale di Todd Haynes con al centro Brian Slade (popstar ispirata a David Bowie e Lou Reed) che lentamente diventa la storia di scoperta e autoaffermazione dell’identità omosessuale del protagonista attraverso la musica, dall’altro in alcuni interessanti progetti dell’inglese John Carney. Non solo Sing Street, su un giovane che nell’Irlanda degli anni ’80 si appassiona alla cultura New Romantic ed al glam rock e si confronta, per questo, con il bigottismo di istituzioni conservatrici come la scuola cattolica da lui frequentata ma anche il precedente Tutto Può Cambiare, un altro film di resistenza e identità, sebbene declinata all’interno del mondo dell’industria musicale. La storia è infatti quella di un produttore musicale che ritrova l’entusiasmo della creazione artistica aiutando una giovane cantautrice ad esordire nella musica che conta, proteggendola dal tritacarne spersonalizzante del music business e ribellandosi, in tralice, ad un suono che sembra guardare con sospetto tutto ciò che è diverso da ciò che già si conosce.
Il racconto metatestuale:
Nel film Gondry costruisce un’opera profondamente metatestuale, in cui il racconto non si limita a narrare una storia, ma riflette in modo esplicito sul fare cinema, sul ruolo dell’autore e sul processo creativo stesso. Il protagonista Marc Becker, regista tormentato e geniale, è l’alter ego trasparente dello stesso Gondry: la sua esperienza personale diventa la materia viva di una riflessione cinematografica sulla creazione artistica, la libertà e il caos interiore dell’autore. Il metatesto nel film opera su diversi livelli, il più evidente è quello narrativo: Marc sta montando un film all’interno del film, e questo processo viene
continuamente interrotto, riscritto, rifiutato o reinventato. L’opera a cui lavora, Chacun tout le monde, non è solo un pretesto narrativo, ma diventa un riflesso sfaccettato dello stato mentale e delle tensioni interiori del protagonista. Il montaggio che Marc vuole sottrarre ai produttori, convinto che la sua visione sia l’unica possibile, è raccontato come una lotta tra creatività e compromesso, tra ispirazione libera e logica industriale. Ma la metatestualità va oltre il semplice film-nel-film perché Gondry dissemina l’opera di commenti indiretti sul cinema stesso. Marc teorizza un linguaggio visivo nuovo, sogna un montaggio non lineare, palindromico, scrive il suo “libro delle soluzioni” come se fosse un manifesto personale. Ogni scelta narrativa o formale nel film parla del bisogno di reinventare i codici, di trovare un equilibrio tra razionalità e immaginazione. La macchina da presa diventa uno specchio, uno strumento terapeutico e uno spazio di ribellione, come fosse essa stessa soggetto e non più solo mezzo. Anche i personaggi contribuiscono a questa stratificazione metatestuale: Charlotte, la montatrice, è la voce della ragione tecnica; Sylvia, l’assistente, rappresenta la fiducia cieca nel genio; Denise, la zia, è il rifugio affettivo ma anche il luogo fisico in cui il processo creativo si scontra con la quotidianità. Tutti gravitano attorno a Marc come attorno a un centro instabile, il cui delirio creativo alimenta e consuma allo stesso tempo la narrazione. Inoltre, Il libro delle soluzioni riflette sul rapporto tra autenticità e rappresentazione. Marc filma ossessivamente tutto: formiche, nuvole, incidenti quotidiani — nella convinzione che ogni cosa possa diventare cinema. Questa smania documentaria diventa anche una critica implicita alle forme standardizzate di narrazione, e si interroga su cosa significhi davvero raccontare. Gondry utilizza il proprio stile visivo caratteristico — animazioni handmade, intermezzi surreali — per ricordare allo spettatore che ciò che si sta guardando non è solo una storia, ma una riflessione sulla matericità che può arrivare ad assumere il cinema. In questo senso, Il libro delle soluzioni non è solo un film, ma un dispositivo metacinematografico che si interroga sul valore della creazione artistica in un’epoca dominata dalla produttività usa e getta. In conclusione, il racconto metatestuale è il cuore stesso dell’opera. Gondry firma una confessione travestita da commedia, un’esplorazione ironica e dolente del caos mentale dell’artista, e un’esortazione a difendere la libertà del pensiero creativo. Il libro delle soluzioni è cinema che si guarda allo
specchio e, pur riconoscendo le proprie crepe, continua a credere nel potere visionario dell’immaginazione.
● L’ansia da prestazione:
Nel film Il libro delle soluzioni, Michel Gondry affronta in modo ironico e struggente il tema dell’ansia da prestazione artistica, restituendo un ritratto vivido e a tratti autobiografico del tormento creativo che colpisce chi è chiamato a trasformare la propria visione in un’opera compiuta. Il protagonista, regista brillante ma instabile, è consumato dalla necessità di completare il montaggio del suo film, sospeso in bilico tra perfezionismo e ribellione. Marc fugge da Parigi per trovare rifugio nella casa della zia Denise, portando con sé la sua troupe più fidata. Questo “esilio creativo” dovrebbe servire a terminare il lavoro, ma si trasforma invece in una fuga da ogni tipo di responsabilità. Lontano dai produttori, Marc si illude di poter lavorare liberamente, ma il peso delle aspettative lo paralizza. Ogni decisione, ogni taglio di montaggio, ogni inquadratura diventa un campo di battaglia tra impulso creativo e paura del fallimento. L’ansia da prestazione si manifesta in forme molteplici: nell’incapacità di scegliere una versione definitiva del film, nel continuo rimandare il momento del confronto con i produttori, nella compulsiva produzione di idee collaterali — dal documentario su una formica alle riprese sperimentali. Marc non riesce a lavorare su ciò che deve fare, perché teme che il risultato non sia all’altezza di ciò che immagina o di ciò che gli altri si aspettano da lui. La scrittura del Libro delle soluzioni è un chiaro tentativo di controllare l’ansia. È la razionalizzazione del caos interiore, un modo per tenere a bada la sensazione di inadeguatezza, pur senza affrontarla direttamente. Gondry, attraverso questo personaggio, mette in scena un’ansia tipica di ogni artista: quella di deludere, di non essere compreso, di fallire nel tradurre la propria immaginazione in qualcosa di concreto. Il film non propone soluzioni vere, ma suggerisce che l’unico modo per affrontare l’ansia da prestazione è accettare l’imperfezione, vivere nel dubbio, e continuare a creare nonostante tutto. Mappa concettuale:
● La reproduction interdite di René Magritte; 1937 dipinto ● Cleo dalle 5 alle 7 di Agnès Varda; 1962 film
● Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino; 1979 romanzo
● Appuntamento a Belleville di Sylvain Chomet; 2003 film ● Grammatica della fantasia di Gianni Rodari; 1973 saggio
● Détour di Michel Gondry; 2018 cortometraggio
● Neighbours di Norman McLaren; 1952 cortometraggio
● All in Line di Saul Steinberg; 2024 illustrazione/fumetto