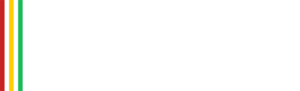Regia: Pablo Berger
Sceneggiatura: Pablo Berger, dalla graphic novel di Sara Varon
Fotografia:Jose Luis Agreda
Montaggio:Fernando Franco
Paese/Anno: Spagna, Francia, 2023
Distribuzione: I Wonder
Durata: 103’
Genere: animazione
Sinossi:
Negli anni ’80 a Manhattan, Cane vive da solo. Dopo aver visto una pubblicità in TV, decide di ordinare un amico robot, che assembla appena arrivato e poi porta in giro per Manhattan, a pattinare a Central Park sulla canzone September. Nel corso dell’estate, i due diventano inseparabili.Quando l’estate sta per finire, Cane porta Robot in spiaggia, dove passano una lunga giornata a giocare in acqua e poi si addormentano. Robot viene però arrugginito dall’acqua e quindi non può più muoversi; il cane è costretto a tornare a casa da solo per la notte. La spiaggia è chiusa fino al 1° giugno dell’anno successivo: dopo alcuni tentativi falliti di attraversare l’inferriata che blocca l’accesso, Cane si arrende e decide di aspettare fino a quando non potrà andare a salvare Robot.
Durante il tempo trascorso immobile sulla spiaggia, Robot sogna vari scenari in cui riesce a scappare dalla spiaggia e tornare nell’appartamento di Cane,per poi svegliarsi eritrovarsi ancora intrappolato tra le dune di sabbia. Una delle gambe di Robot viene anche mozzata da alcuni conigli canottieri.
Una scimmia si intrufola sulla spiaggia e trova Robot sepolto con il suo metal detector, e lo porta in una discarica per venderlo. Quando finalmente arriva il 1° giugno, Cane torna in spiaggia ma riesce solo a trovare la gamba abbandonata.
Un procione di nome Rascal visita la discarica e scopre la testa e le membra rimanenti di Robot. Compra i pezzi e li porta a casa, ricostruendo Robot con uno stereo boombox come nuovo corpo. Nel frattempo, Cane compra un nuovo amico robot chiamato Tin. Durante l’estate, Robot e Rascalsi affezionano, così come Cane e Tin.
Mentre Robot e Rascal pranzano sul tetto, Robot guarda giù e vede Cane e Tin camminare sul marciapiede. Decide di non inseguire Cane, ma di usare il suo corpo da boombox per far risuonare la canzoneSeptemberfin nella strada. Cane sente la canzone e i due ballano insieme a distanza per l’ultima volta, senza vedersi.
Recensione:
Il mio amico Robot è il terzo film di Pablo Berger e Arcadia Motion Pictures dopoBlancanievese Abracadabra.Il mio amico Robot ha rappresentato una grande sfida per il regista spagnolo, trattandosi del suo primo lungometraggio di animazione in 2D. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al 76° Festival di Cannes nella sezioneSéancesSpéciales. Ha vinto il premio come miglior film nella sezione Contrechamp del Festival internazionale del film d’animazione di Annecy, nonché come miglior film d’animazione indipendente al 51esimo Annie Awards. Ha vinto anche il Goya Award per il miglior film d’animazione e l’European Film Award per il miglior film d’animazione, ed è stato nominato come miglior film d’animazione alla 96esima edizione degli Academy Awards.
Lo stile sia del film che della graphic novelRobot Dreams di Sara Varon, alla base dell’opera, prende spunto dalla linea chiara della scuola franco-belga e di uno dei suoi maggiori esponenti, Hergé, autore di Tintin. La realtà viene narrata e rappresentata usando linee chiare e continue, colori piatti e poche ombre. Questo stile è tornato alla ribalta negli anni ‘80 grazie ai fumetti di Serge Clerc, Yves Chaland o Floc’h. In Spagna è diventato famoso con Cairo e Daniel Torres. Ma è molto presente ancora oggi grazie a fumettisti come Adrian Tomine e Chris Ware. A detta di Pablo Berger,Il mio amico Robot è stato concepito come un fumetto che “diventa” disegni animati. Per farlo, sfrutta le caratteristiche tipiche di entrambi i media e la tecnica del panfocus, una tecnica fotografica che permette di tenere a fuoco l’insieme degli elementi presenti nell’inquadratura, e di giocare con la profondità di campo.
Il mio amico Robot è un film con lo sguardo rivolto al passato, all’animazione tradizionale, ma concepito per il pubblico odierno: quella tra Cane e Robot, o tra Robot e Rascal o tra Cane e Tim, è amicizia o amore (iniziano ad esempio ben presto a tenersi la mano)? Ed è davvero importante definirla nell’uno o nell’altro modo? L’ambientazione nel mondo degli animali aiuta l’universalità dei sentimenti tirati in ballo: di Duck, ad esempio, è più importante la sua natura di animale migratore (che si trasferisce infatti a Barcellona), che avere la certezza del suo genere sessuale d’appartenenza – così come la frequentazione di Cane col pupazzo di neve non può che essere transitoria, la neve non potrà mai essere perenne.
L’animazione classica, in due dimensioni, disegnata fotogramma per fotogramma, ha un’espressività, un’umanità e un’empatia tutte sue. Lo sguardo dei personaggi animati è l’elemento essenziale che sostituisce i dialoghi, che nel film sono assenti. Il design del suono del film è una giungla sonora – dagli ambienti e i suoni domestici alle strade affollate e rumorose dei vari quartieri di New York. Il design del suono di Il mio amico Robot è la sua terza dimensione. Non è un caso che il silenzio della spiaggia dove Robot finisce immobilizzato sia proprio il silenzio delle macchine (la ruota panoramica ferma, tutte le strutture estive spente), il robot finisce “rottamato” ben prima della discarica, attrazione abbandonata tra simili attrazioni smantellate, chiuse per l’inverno.
Questo livello di metafora è tipico delle storie di Sara Varon, che sono favole abitate dagli animali più disparati, animali che assumono comportamenti umani e che coesistono in una riconoscibilissima e nostalgica New York (la versione animata di Pablo Berger si diverte poi ad aggiungere una lunga lista di citazioni di immagini oramai storiche di film ambientati a Manhattan e dintorni). La diversità della fauna riflette perfettamente il mix di culture ed etnie che popola la Grande Mela, un universo cinematografico in cui il montaggio, la composizione dell’immagine, il punto di vista, la poesia visiva, le ellissi e i fuori campo sono elementi essenziali per raccontare la storia di Cane e Robot. È vero infatti che il film rinuncia ai dialoghi (come molta animazione recente, d’altronde, si veda l’ultimo Flow – Un mondo da salvare), ma la playlist musicale incentrata sulle hit degli anni ’80 si sostituisce alle parole tra i personaggi, così come il commento jazzato delle musiche originali di Alfonso de Vilallonga, che sembrano rifarsi apertamente ai meravigliosi accompagnamenti delle avventure a cartoni dei Peanuts (a proposito di animazione “esistenzialista”…) firmati ed eseguiti dal grande Vince Guaraldi.
José Luis Ágreda è uno degli illustratori spagnoli più importanti da 25 anni. Il suo lavoro eccezionale nel film d’animazione Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe (2019) e la sua esperienza presso il prestigioso studio di animazione Cartoon Saloon lo hanno reso la prima scelta di Berger per il ruolo di direttore artistico deIl mio amico Robot: una squadra di 20 artisti, sotto la direzione di José Luis, ha sviluppato concetti, personaggi, sfondi, oggetti di scena, storyboard, soprattutto la giungla variegata dei newyorchesi – centinaia, anzi, migliaia di personaggi-comparse (tra cui un’apparizione di un inequivocabile murales di Basquiat!). Tenete gli occhi aperti.
Approfondimenti:
IL TEMA DEL MUTUO SOCCORSO
Cane e Robot fanno un riposino dopo la giornata al mare, e quando si risvegliano sono rimasti gli unici ancora sulla spiaggia, al tramonto. A causa della lunga immersione subacquea che i due hanno fatto la mattina, Robot non riesce più a muovere il proprio corpo, nonostante i numerosi tentativi di Cane di rimetterlo in moto o di trascinarlo via dalla sabbia: con un movimento degli occhi, il robot consiglia al suo compagno di abbandonarlo lì, e di tornarsene a casa. Cane, con le lacrime agli occhi, infila lo zaino e torna in città. Nei giorni successivi, lo vedremo tentare più volte di reintrodursi nello stabilimento oramai chiuso al pubblico, invano: spesso non è colpa di nessuno quando finisce una relazione, un’amicizia, o si spezza un legame. Nell’ingenuità delle prime fasi di un affetto, non ci si rende conto di stare commettendo delle leggerezze, come bagnare con l’acqua una creatura meccanica: ma quando uno dei due sta male, non è detto che l’altro sappia davvero cosa sia meglio fare, come intervenire sulla situazione di chi è rimasto bloccato, incastrato, infortunato. Possiamo davvero fare una colpa a Cane per aver portato entusiasticamente Robot in acqua, lui che sembrava solo aspettare quel momento da una vita intera (e d’altra parte la loro nuotata è stata meravigliosa)?Così come non possiamo negare che ce la metta tutta pertentare di trovare il modo efficace per aiutarlo, per salvarlo, senza riuscirci per quanto possa sforzarsi, ingegnarsi, tentarci. Robot ha dato un apporto fondamentale alla vita di Cane, e lui non è stato capace di prendersene cura fino in fondo – non gli resta che accettarlo. L’unica cosa che possiamo tenere a mente, è di fare tesoro degli errori commessi quando la vita ci metterà nuovamente di fronte ad una situazione simile: e infatti, vedremo Cane nel finale evitare che il suo nuovo robot Tin avvicini anche soltanto un piede all’acqua dell’oceano, quando i due andranno al mare.
L’ANIMA CINEFILA DEL FILM
Si tratta di una delle sequenze oniriche, i robot dreams appunto, in cui Robot sogna diverse versioni del suo ritorno a casa da Cane: quello che scegliamo è in assoluto il frammento più “astratto” de Il mio amico Robot, che gioca con la quarta parete filmica e insieme esplicita definitivamente la cifra cinefila dell’opera. Robot è al cospetto di quello che sembra uno schermo cinematografico, e prova invano ad uscire dalle pareti dell’inquadratura; il personaggio allora con un colpo rovescia la “facciata” dello schermo, che rivela dall’altro lato un’ambientazione palesemente riferita a Il mago di Oz, il classico di Victor Fleming del 1939 che in VHS Robot e Cane guardavano spesso sul divano di casa – non è casuale, dato che si tratta di un’avventura che coinvolge “uomini di latta” e animali antropomorfi, e soprattutto di una delle storie più rappresentative del tema del “ritorno a casa”… A questo punto, Robot “salta” nell’immagine e finisce nella sua versione della storia diOz, dove la Città di Smeraldo ha lo skyline di New York e dove alla fine dell’arcobaleno c’è proprio la casa di Cane. Siamo nella sequenza nel campo di papaveri della storia di L. Frank Baum, esattamente quel campo che i personaggi del romanzo non riescono ad attraversare per un incantesimo della Strega, che fa sì che Dorothy cada a peso morto tra i fiori e sia impossibile spostarla, o trascinarla altrove. Ovvero la situazione di Robot, il quale però, all’opposto, sogna una straordinaria coreografia con un campo di margherite animate che lo fanno ballare, saltare, portano la primavera nel suo inverno di desolazione e immobilismo (con i fiori che sincronizzano i propri movimenti per disegnare nel campo il volto sorridente di Cane). Ma, appunto, è solo un sogno, e la facciata del palazzo di Cane è destinata a rivelarsi come un’impalcatura del set, una quinta, che casca addosso al robot e lo risveglia nel suo stallo di corpo meccanico abbandonato sulla sabbia ricoperta dalla neve.
I RICORDI E LE NUOVE VITE
Nonostante le sue digressioni marittime o montane, Il mio amico Robot è però un film inequivocabilmente metropolitano, legato fortemente all’immaginario di una New York su cui svettano ancora le Torri Gemelle. E dunque la visione non può che essere verticale, come la città che si spinge verso l’alto con i suoi grattacieli: e appunto dall’alto dell’oblò del loft in cui vive con Rascal (qualcuno potrebbe rilevare una somiglianza con la finestra da cui si affaccia Cesare, la scimmia senziente del Pianeta delle Scimmie), Robot vede passeggiare Cane in compagnia di Tin. La riconciliazione è anche stavolta solo sognata, e pure qui con una forte valenza metaforica: Robot e Cane si riabbracciano ad un incrocio stradale, simbolo appunto di una situazione di stallo, di passaggio, con il semaforo verde che intima a Cane “walk”, cammina, prosegui nella tua nuova vita, passa oltre. E allora, nella dimensione reale, rimane giusto il tempo di riascoltare un’ultima volta insieme Septemberdegli Earth, Wind and Fire, anche se fisicamente divisi dalla città, Cane sul marciapiede e Robot sul terrazzo del proprio loft: la musica, il vero linguaggio della connessione per tutto il film, riunisce i due personaggi nella stessa coreografia come accaduto a Central Park all’inizio della loro storia, grazie alla magia dello split screen, l’espediente di montaggio che tiene insieme nella stessa inquadratura due porzioni appartenenti a sequenze differenti, che possono (come in questo caso) svolgersi in maniera parallela. Ma è solo un attimo, la vita di Cane si svolge ormai secondo un ritmo differente, quello ballato ogni giorno insieme a Tin: Septemberresterà comunque sempre – letteralmente – nel cuore da stereo del robot, nella cassettina che recita “le canzoni preferite da Robot”, dove potrà essere risuonata tutte le volte che vorrà, dando il via alla carrellata dei ricordi. Gli ultimi suoni che Pablo Berger ci fa ascoltare, però, sono coerentemente dedicati ai rumori della città, il sottofondo metropolitano che ha fatto da reale colonna sonora a tutta la vicenda.
RIFERIMENTI
1.Il gigante di ferro (1999), di Brad Bird
2. Soul (2020), di Pete Docter
3.Entergalactic (2022), di Fletcher Moules